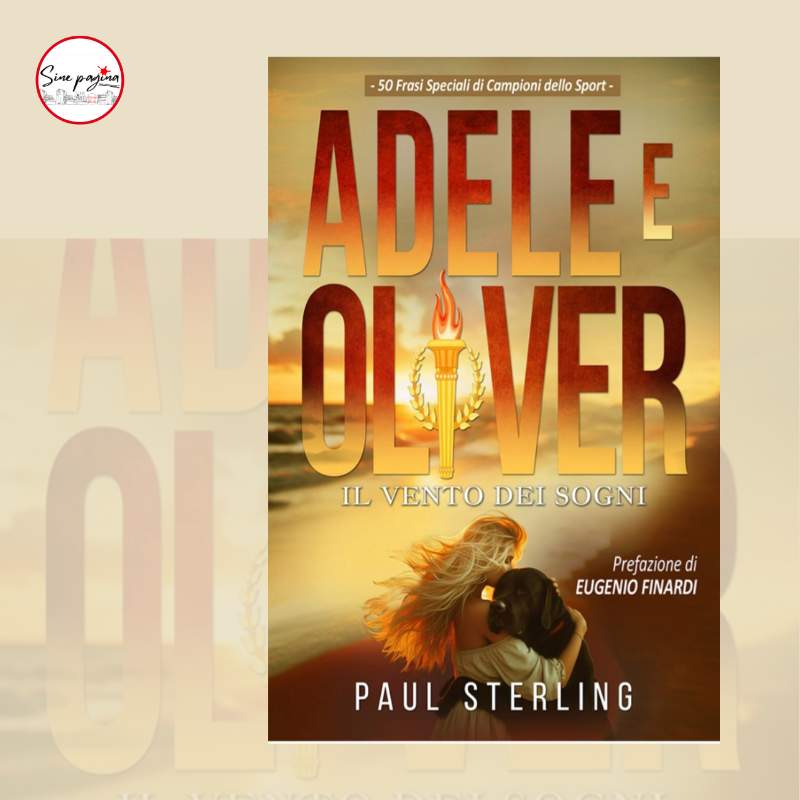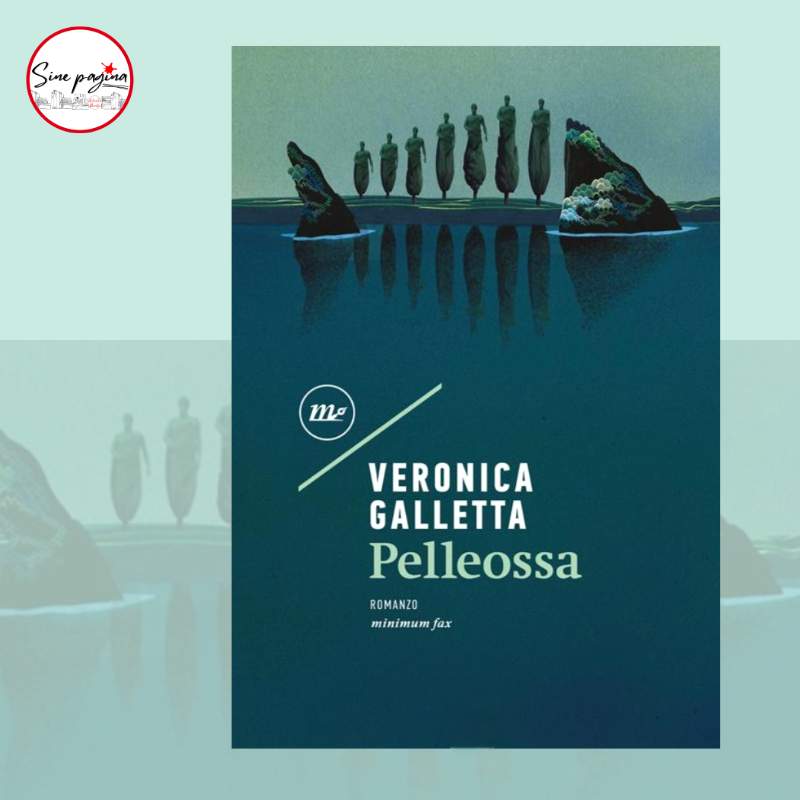Racconto di Antonella Perrotta
In tutti quegli anni passati in Francia, io, Vincenzo Peruggia, avevo imparato a riconoscere l’espressione dei francesi quando si rivolgevano a me, compresa quella di tutti i signorotti che stavano al Louvre. Dall’alto in basso mi guardavano e, invece, avrebbero dovuto avere rispetto per me e anche per i miei connazionali. Quasi lo stesso rispetto che dimostravano per un genio come Leonardo da Vinci, ad esempio, che era italiano pure lui.
Eh! Ma se avessero saputo ciò che la mia mente aveva partorito! E quello che era stata in grado di mettere in pratica! Ero convinto che avrebbero abbassato il capo, profondamente umiliati per essere stati presi per i fondelli da un italiano che suonava il mandolino e mangiava i maccheroni. Povero illuso, direte voi. E oggi, con l’esperienza del poi, lo dico anch’io. Povero illuso!
Potrà sembrarvi strano ma, quando giunsi al Museo e trovai un gran caos, mi venne da ridere. Un incisore e un pittore che avevano avuto il permesso di dedicarsi ai loro studi artistici proprio al Louvre, nel giorno di chiusura, quando nessuno avrebbe potuto disturbarli, si erano accorti per primi del vuoto sulla parete e avevano dato l’allarme. Così, tutti erano lì a chiedersi che fine avesse fatto la Gioconda, se fosse stata rubata o solo temporaneamente rimossa per essere fotografata e, nel mentre, si affannavano a cercarla dappertutto, nello studio fotografico, nelle altre sale del Museo e anche nei ripostigli e nei sottoscala, perché non era possibile, neanche immaginabile, che qualcuno avesse osato rubarla e farla franca così.
Avreste dovuto vederli! Che ridere! Anche a me chiesero se ne sapessi qualcosa, ma io feci il furbo, feci spallucce e mi finsi ancora mezzo intontito dalla sbronza e dal sonno. Che ridere, mamma mia!
E risi ancor di più quando seppi che il sottosegretario alle Belle Arti del governo francese, messo al corrente dell’accaduto, andò su tutte le furie. Pare che fosse appena andato in vacanza raccomandandosi di non essere disturbato per niente al mondo. “Chiamatemi solo se rubano la Gioconda!” aveva detto ai suoi collaboratori, così, tanto per dire, e s’era fatto una risata. Povero sottosegretario!
Ma, in quel momento, ero io a ridere. Non riuscivo proprio a smettere al pensiero di essermi fatto beffe del sottosegretario, del direttore del Museo, del capo della sicurezza, del capo della polizia, del prefetto di Parigi e pure di tutti i parigini che, potenza del passaparola, affollavano l’ingresso del Louvre per saperne di più su quell’incredibile furto.
E, sapete, risi ancor di più quando proprio il prefetto di Parigi, monsieur Louis Lépine, perquisì casa mia, così come aveva fatto con le abitazioni di tutti i lavoranti al Louvre, senza accorgersi di lei, la Gioconda, che stava nascosta proprio sotto lo stesso tavolo su cui stava firmando il verbale di perquisizione. Che ridere, mamma mia! Che ridere!
Voi che dell’accaduto avete riempito le pagine dei giornali sapete meglio di me ciò che successe dopo: la gendarmeria brancolò nel buio, l’intera Francia venne messa sotto sopra, i responsabili del Museo vennero messi alla gogna per aver subito il furto di un dipinto per la prima volta nella storia, gli Amici del Louvre annunciarono una ricompensa di venticinquemila franchi per chi avesse dato notizie utili al ritrovamento, l’Impero tedesco venne sospettato di furto di Stato e, di furto, vennero sospettati anche il poeta Apollinaire e l’artista Picasso.
Nel frattempo, Monna Lisa se ne stava lontana dal sole, nella cucina buia e spoglia della pensioncina in Rue de l’Hopital Saint Louis in cui vivevo. Che ridere! Non riuscivo proprio a smettere!
Due anni l’ho tenuta lì, in uno spazio ricavato sotto al tavolo, e ogni mattina all’alba, prima di andare al lavoro, la tiravo fuori e la guardavo estasiato, mentre bevevo il mio caffè, avvolto dalla luce calda della candela. Era una fortuna che ci fosse lei, che era italiana proprio come me e che, se fosse stata in carne e ossa, sarebbe stata la mia amata.
La visione del volto di quella creatura che sorrideva, dolce e sensuale, e pareva respirare come fosse viva riusciva a riscaldarmi il cuore e a ricordarmi casa. A volte, le parlavo pure. “Mamma mia, quanto sei bella!” le dicevo. E lo stesso le dicevo anche la sera, quando mi concedevo il piacere di un piatto di pasta al sugo di pomodoro, cotto lento, alla maniera italiana e, così, concludevo la mia giornata, faticosa, uguale alle altre.
Mentre che la miravo e rimiravo, mi veniva da pensare a quel ladro di Napoleone che aveva fatto lo stesso e pure a tutti quei parigini che, adesso, affollavano il Louvre per vedere soltanto un chiodo.
Per me era una soddisfazione sapere che, anche se al Louvre il posto sulla parete lasciato vuoto dalla Gioconda era stato occupato da un’opera di Raffaello, non fosse tanto quell’opera, il ritratto di Baldassarre Castiglione, ad attirare l’attenzione della gente, quanto piuttosto il posto stesso che occupava. Quel posto era diventato per i visitatori importante come la Gioconda stessa.
Chissà se qualcuno avrebbe avuto ancora il privilegio di ammirarla, si chiedevano con lo sguardo rivolto al dipinto di Raffaello e, così, finivano inevitabilmente per pensare sempre a lei che chissà dove stava e chissà se si sarebbe mai ritrovata.
Tutto il mondo in quei giorni si chiedeva della Gioconda.
Tutto il mondo pensava a lei, mentre io, nel frattempo, mi dicevo: tempo al tempo. Tempo al tempo, mi dissi durante tutti quei mesi, ventotto per la precisione, in cui pazientai, in attesa di trovare il momento giusto per riportarla a casa.
E, poi, quel tempo, finalmente, arrivò.
Fu quando lessi un annuncio pubblicato sui giornali dall’antiquario fiorentino Alfredo Geri che chiedeva in prestito ai privati alcune opere da esporre in una mostra che avrebbe organizzato nella sua galleria a Firenze, che capii che, proprio quella, era l’occasione che stavo aspettando.
Così, gli scrissi una lettera firmandomi Vincent Leonard: “Il quadro è nelle mie mani. Appartiene all’Italia perché Leonardo è italiano.” E aggiunsi che l’avrei restituito solo se avessi avuto la garanzia che sarebbe rimasto in Italia e se mi fossero state pagate cinquecentomila lire. Per coprire le spese, sia ben chiaro, mica per guadagnarci. Sapevo bene quanto valesse il ritratto. Un valore inestimabile, direi, altro che cinquecentomila lire!
Un po’ mi dispiaceva liberarmene, ma il mio piano doveva essere portato a termine. La Gioconda doveva essere restituita agli italiani. Meritava di essere ammirata e apprezzata da tutti i suoi connazionali e non di starsene sotto al tavolo della cucina di una misera pensioncina di Parigi esposta agli unici, se pur incantati, sguardi di un umile imbianchino come me.
E mentre aspettavo la risposta dell’antiquario, mi maceravo nell’ansia, chiedendomi se questo contatto avrebbe funzionato o se, invece, sarebbe morto nel nulla come il precedente, quello con l’antiquario londinese Duwen, cui pure avevo scritto del quadro.
Ma, poi, la risposta arrivò: il signor Geri fissò un incontro con me e con lei, la Gioconda, all’Hotel Tripoli, in via dei Cerretani a Firenze, per l’undici di dicembre.
Riportare il dipinto a casa, in Italia, non fu poi complicato. Lo nascosi in valigia, fra le mutande e i calzini che ero sicuro i doganieri non avrebbero guardato e che, difatti, non guardarono. La Gioconda riuscì a passare indisturbata la frontiera, prendendosi gioco anche delle guardie cui sorrise, ironica e sfuggente, dall’interno della valigia.
Per l’incontro con l’antiquario indossai una camicia pulita e la mia unica giacchetta buona. Faceva freddo, era quasi Natale, ma io non lo avvertivo. Me ne andavo per le strade di Firenze in compagnia della Monna Lisa come se fosse la cosa più normale del mondo. Il mio unico pensiero era quello di giungere in perfetto orario all’appuntamento al Tripoli. Pregustavo già la reazione di Alfredo Geri alla vista del ritratto e anche il suo compiacimento quando gli avrei rivelato che l’avevo preso dal Louvre e tenuto con me per tutti quei mesi all’unico fine di restituirlo all’Italia.
Quell’undici di dicembre del 1913, credevo, sarebbe stata una data storica per l’arte del nostro Paese: il giorno in cui la Gioconda, il capolavoro di Leonardo da Vinci, aveva fatto ritorno a casa.
Povero illuso! direte voi. Povero idealista! dico, invece, io che con questo pensiero in testa riuscii anche a sorridere quel giorno, nonostante il nervosismo e la preoccupazione.
Ero impaziente di restituire il dipinto e, perciò, affrettai il passo. L’antiquario mi stava attendendo con la medesima impazienza alla stanza numero venti, al terzo piano, dell’hotel. Con lui, un uomo che mi venne presentato come il direttore degli Uffizi, tal Giovanni Poggi. Io consegnai loro la Gioconda senza troppe ciance.
“La rendo al suo Paese e a tutti gli italiani” dissi soltanto e tirai un sospiro di sollievo.
I due uomini l’osservarono. Dapprima, da lontano. Poi, le si avvicinarono e cominciarono a guardarla bene da tutte le angolazioni, di fronte e nel retro, maneggiandola con attenzione. Si scambiarono uno sguardo che non seppi interpretare. Enigmatico, come quello della Monna Lisa.
L’antiquario Geri parlò per primo, mentre il direttore degli Uffizi annuiva d’intesa. “Signor Leonard, capisce che abbiamo bisogno di verificare l’autenticità dell’opera che ci ha appena consegnato. La terremo con noi e, solo in caso positivo, tratteremo la sua richiesta in denaro. Ci sentiremo presto” mi disse.
Ma io feci spallucce. Anche se quei soldi mi avrebbero fatto comodo, era la promessa che il dipinto sarebbe rimasto per sempre in Italia a interessarmi.
Era quello il motivo, il vero motivo, per cui l’avevo preso dal Louvre.
Che sia chiaro una volta per tutte.
(Continua…)