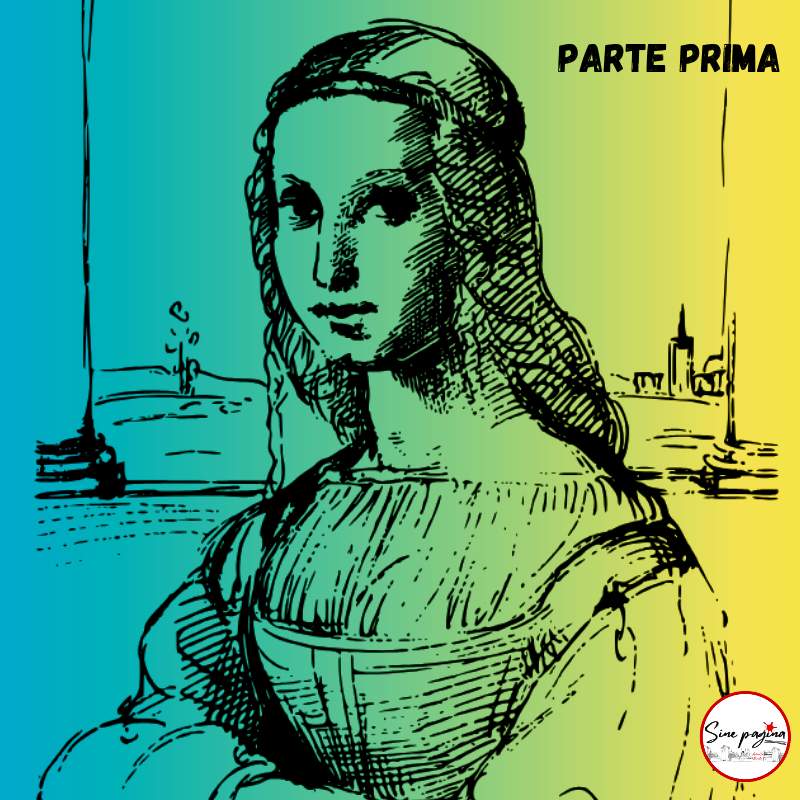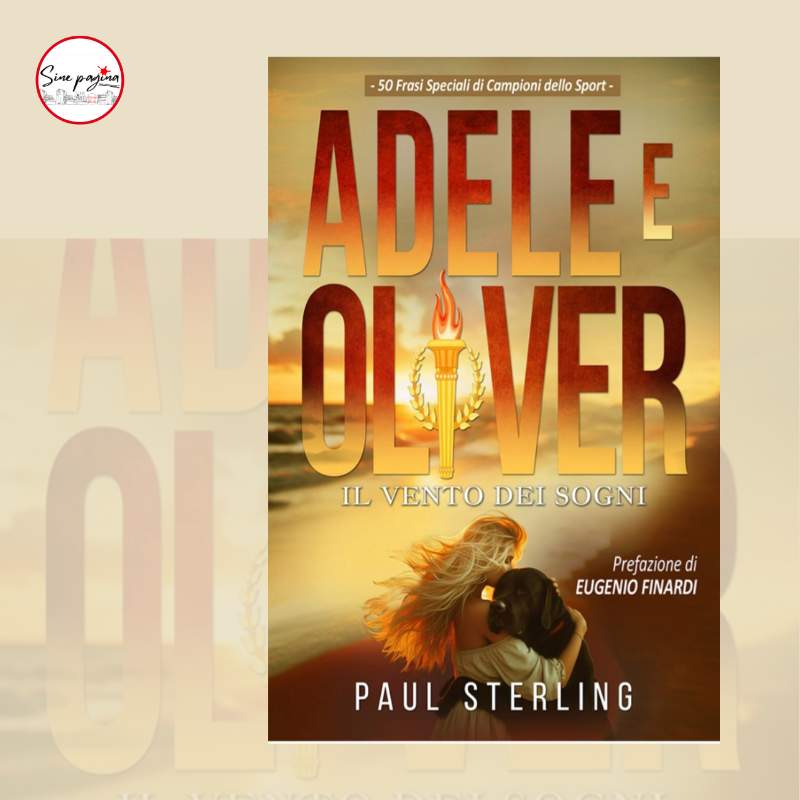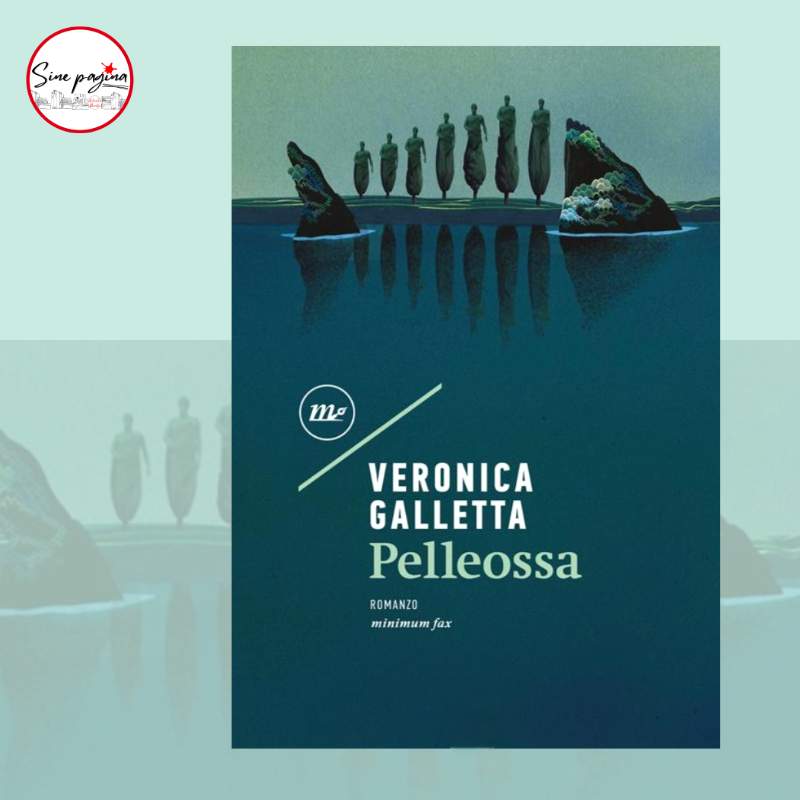Racconto di Antonella Perrotta
È una giornata assolata di fine luglio dell’anno 1914.
Finalmente, esco di prigione.
Il sole mi acceca, mi costringe a pararmi gli occhi con le mani, ma riesco a distinguere ugualmente degli uomini ben vestiti fermi sulla strada.
Stanno aspettando me.
Mi vengono incontro. Sono giornalisti, sicuramente. Lo capisco dai taccuini che hanno in mano, dal passo deciso e dall’espressione determinata di chi è intenzionato a rivelare la verità dei fatti. Penso vogliano conoscere la mia, di verità, quella che non è del tutto emersa nel corso del processo in cui sono stato condannato a sette mesi, seppure con le attenuanti.
Al carcere delle Murate a Firenze l’ho trascorsi questi lunghi, difficili mesi, durante i quali il rammarico che il mio gesto non fosse stato capito ha prevalso su tutto, anche sul freddo che ho sofferto, anche su quella cappa ferrigna che mi ha avvolto tutto, fino all’anima. Mi sono sentito solo. Trattato come un criminale qualunque. Un ladro, un truffatore.
Venite, giornalisti dallo sguardo convinto. Fatemi le vostre domande e io saprò darvi le risposte che cercate. Riuscirò, questa volta, a raccontarvi la mia verità.
“Vincenzo Peruggia: il ladro della Gioconda” avete scritto sulle prime pagine dei vostri giornali e io ho pensato che non vi foste preoccupati affatto di comprendere chi fossi io realmente e non aveste riflettuto sul fatto che rubare è una parola grossa, pesante, se riferita a chi, come me, sarebbe potuto diventare ricco, ricchissimo, se solo avesse voluto, piuttosto che ritrovarsi senza un lavoro e senza un soldo in tasca. Ma è giusto che sappiate che non ho mai voluto tenere il dipinto per me né specularci sopra. È giusto che tutti sappiano che non ho mai voluto nulla, in realtà. Nessun favore, nessun soldo. Un grazie, magari, quello sì.
Perciò, miei bei giornalisti dal volto rasato, io non sono un ladro. Non sono un criminale. Pure se mi hanno fatto fare la galera.
Sono un semplice imbianchino e verniciatore, invece, nato nel borgo di Trezzino, una frazione di Dumenza, emigrato in Francia che ero ancora un ragazzetto. È stata dura la mia vita ed è stato duro il mio mestiere, buono soltanto a lasciarmi due lire in tasca mentre mi recideva i sogni come un taglialegna fa coi rami degli alberi e sfocava tutti i miei ideali come nebbia sfoca l’orizzonte. Pure una bella intossicazione da piombo mi ha provocato: saturnismo, la diagnosi dei medici, mica niente.
Ma, poi – e di questo siete già a conoscenza – a Parigi mi sono messo a lavorare per la ditta del monsieur Gobier che curava la manutenzione interna del Louvre, mica un posto qualsiasi. Avevo il compito di pulire i quadri e montare le teche di protezione in cristallo e questo era per davvero un gran bel lavoro. Non perché mi rendesse ricco – figurarsi, vivevo in una misera pensioncina insieme a mio cugino Luigi, per dividere le spese e farci compagnia – ma perché mi offriva il privilegio di poter ammirare da vicino delle opere d’arte prestigiose e bellissime.
Me li gustavo nei minimi dettagli, quei capolavori, con calma, come fossero caramelle di zucchero. Sentivo che ognuno mi trasmetteva qualcosa di buono, quasi mi ricordasse i sogni e gli ideali d’un tempo. Riuscite a capire cosa voglio dire? Certo, qualcuna mi piaceva di più, qualcuna di meno ma, in fondo, io che non avevo studiato che potevo saperne d’arte?
Una cosa, però, la sapevo e l’avevo sempre saputa: che il ritratto di quella donna dal sorrisetto beffardo che pare prendersi gioco del mondo e che tutti chiamano la Gioconda o Monna Lisa, l’aveva dipinto un genio italiano, Leonardo da Vinci. Se italiano era l’artista, italiana era l’opera – pensavo – e non potevo fare a meno di rimuginare sul fatto che il Louvre non fosse il suo posto e che non fosse giusto che i francesi potessero ammirarla e gli italiani, invece, no.
Be’, chi mi ha fatto fare la galera sicuramente la pensa diversamente da me e, probabilmente, la pensate diversamente pure voi che siete accorsi qui per intervistarmi. Ma il mio cuore mi diceva che quel dipinto apparteneva agli italiani. E il mio cuore continua a ripetermi la stessa cosa pure oggi, nonostante il processo e la condanna. Penso che anche il vostro, di cuore, dovrebbe dirvi l’identica cosa. Lo fa, miei cari giornalisti? Oppure è vicino a quello dei francesi che, la Gioconda, se la sono rubata?
E già. Perché, anche se in molti sostengono che non sia andata così, io ho sempre creduto che sia stato quel ladro – lui, sì, ladro per davvero – di Napoleone Bonaparte a trafugarla e portarla in Francia per tenerla nella sua camera da letto alle Tuileries e ammirarla da vicino insieme a sua moglie Giuseppina. Ladro e impunito quel francese lì, che si è pure autoincoronato imperatore.
E Dio solo sa come, a questo pensiero, mi veniva la bile ogni volta che al Museo mi ritrovavo di fronte al ritratto. Mi veniva al punto da cominciare a maturare l’idea che qualcuno, prima o poi, avrebbe dovuto riportarlo dove sarebbe dovuto stare. Sì, lo so, sarebbe spettato al governo francese restituire la Gioconda agli italiani e al governo italiano fare carte false per riaverlo indietro ma, evidentemente, entrambi avevano qualcosa di meglio o di più importante di cui occuparsi.
Per questo pensai di provvedervi da solo. Sarei stato io a riportare a casa la Gioconda e il governo italiano – ne ero più che certo – mi avrebbe ricoperto di gratitudine per il mio gesto patriottico. Bisognava soltanto che organizzassi la cosa, il furto, insomma, che però – capite bene, miei cari giornalisti – non era un vero e proprio furto. Affatto.
Era un atto di giustizia, piuttosto.
Lo so di non essere una mente, ma non sono neanche uno sciocco, pure se in molti, voi compresi, possano pensarlo. Innanzitutto, pensai bene di crearmi un alibi. Trascorsi la serata del 20 di agosto del 1911 al Café Rubichat insieme ad alcuni amici miei, italiani pure loro, avendo cura di essere notato. Cantai, suonai il mandolino e bevvi vino. Parecchio vino. Al punto da potermi facilmente fingere ubriaco fradicio e farmi fare una multa per schiamazzi notturni. Di tarda, l’ora era tarda e che fossi ubriaco avrei sfidato chiunque, anche le guardie che mi avevano multato, a non crederci. Ma io, invece, ero lucido come i cristalli con cui ricoprivo le opere d’arte al Museo.
L’indomani mattina che erano ancora le sette, uscii da casa quatto quatto ed entrai al Louvre senza farmi vedere da nessuno. Era lunedì, il Museo era chiuso e il custode dormiva profondamente, come al suo solito. Quell’uomo – lo sapevo bene – pareva avere la malattia del sonno, pure se continuava a giustificarsi dicendo che, per mestiere, doveva star sveglio di notte e dormire di giorno.
Non mi fu difficile raggiungere il Salon Carrè.
Lei stava lì.
Mi fissava col suo abituale sguardo profondo e mi sorrideva col sorriso ermetico di sempre. Ma, d’altronde, sebbene fosse talmente perfetta da sembrare vera, era solo una pittura, mica una donna in carne e ossa. Immutabile nel tempo, quindi. Fissa per l’eternità nelle fattezze e nell’espressione che Leonardo le aveva dato.
“E adesso vieni con me. Ti riporto a casa” le dissi col cuore in tumulto e la staccai dal chiodo. Nonostante fosse una tavola di legno di pioppo di settantasette per cinquantatré centimetri soltanto, la parete senza di lei rimase spoglia, triste, con quel chiodo solitario in bella vista.
“Ben ci sta ai francesi!” pensai e, per un attimo, provai un immenso piacere nel vedere il vuoto che avevo creato. Mi liberai, allora, della cornice e del vetro che io stesso avevo montato e avvolsi il ritratto nella giacchetta da lavoro che portavo indosso. Era un bene che fosse così piccolo.
Uscii dal Louvre con tutta calma, senza dare nell’occhio. In strada, a quell’ora, l’aria era ancora fresca, rigenerante. La respirai a pieni polmoni e sentii l’ansia smorzarsi. Ce l’avevo fatta. Era stato davvero facile, peccato non averlo fatto prima. Adesso, lei, la Gioconda o Monna Lisa, era lì, insieme a me, avvolta nella mia giacca.
Capite che emozione? Che grande privilegio, il mio?
Un privilegio che avrei di lì a poco condiviso con tutti gli italiani come me. Mi scappò un sorriso al pensiero di ciò che i giornali avrebbero scritto in prima pagina quando avrei riportato il dipinto in Patria: “Un semplice imbianchino ha fatto ciò che nessuno aveva mai avuto il coraggio di fare: ha restituito il capolavoro di Leonardo da Vinci all’Italia e agli italiani.”
Mi sentivo orgoglioso del mio gesto. In un colpo solo avevo riscattato la Gioconda e mi ero vendicato di tutti quei francesi lì che, per anni, mi avevano deriso chiamandomi Mangia maccheroni e avevano deriso pure il mio mandolino, come se non fosse uno strumento musicale pure quello e la sua musica non fosse musica.
Ma, tempo al tempo. In quel momento, dovevo soltanto mantenere la calma e portare a termine il mio piano. Dovevo tornare a casa e nascondere bene lei, la Gioconda, lontano dal sole e in un ambiente umidificato al punto giusto, così come avevo appreso al Museo. Al resto avrei pensato dopo.
Salii sul primo autobus. Maledizione! Ero salito sul mezzo sbagliato! Quello non mi avrebbe riportato a casa! Scesi, allora, il prima possibile, tenendo ben stretto il dipinto avvolto nella giacchetta, e presi un taxi, per essere sicuro di non sbagliare ancora.
“Rue de l’Hopital Saint-Louis” dissi all’autista. “Di fretta” stavo per aggiungere, ma mi morsicai la lingua. Meglio muoversi con indifferenza per non dare nell’occhio, pensai.
Quando arrivai a casa, mio cugino dormiva ancora profondamente, anche se si sarebbe alzato da lì a poco. Non si era accorto della mia assenza e non se n’era accorta neanche madame Delò, la portinaia, pettegola come tutte le portinaie, dalla quale mi ero guardato bene di farmi vedere. Nascosi la Gioconda in uno spazio sotto al tavolo della cucina e mi rimisi a letto. Feci finta di dormire ma, in realtà, ero ancora galvanizzato. Alle nove circa, uscii nuovamente e, questa volta per davvero, mi feci vedere dalla Delò.
“Signora mia, che sbronza ieri sera! Stamattina non riuscivo ad alzarmi neanche con le cannonate! Speriamo solo che al Museo non mi facciano problemi per il ritardo ché, lei lo sa, come ci vanno duri con noi poveri lavoranti!” le dissi, come se stessi andando di fretta e, lo ricordo bene, feci anche una smorfia quasi fossi ancora stordito dal sonno.
“Veloce! Veloce, su!” mi rispose quella e guardò l’orologio.
Che furbo! E dire che in molti pensavano fossi un mezzo matto!