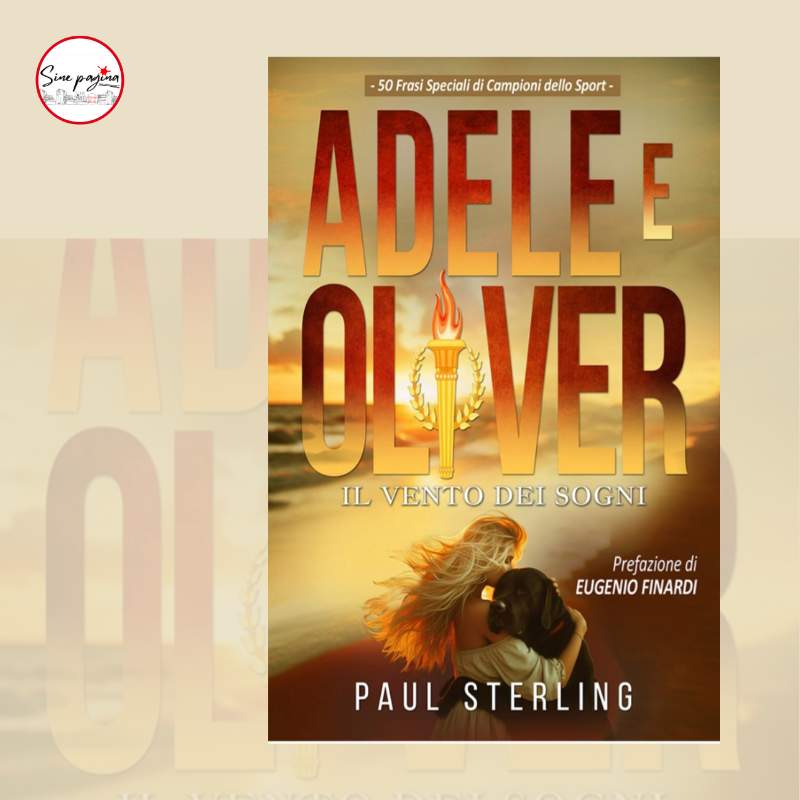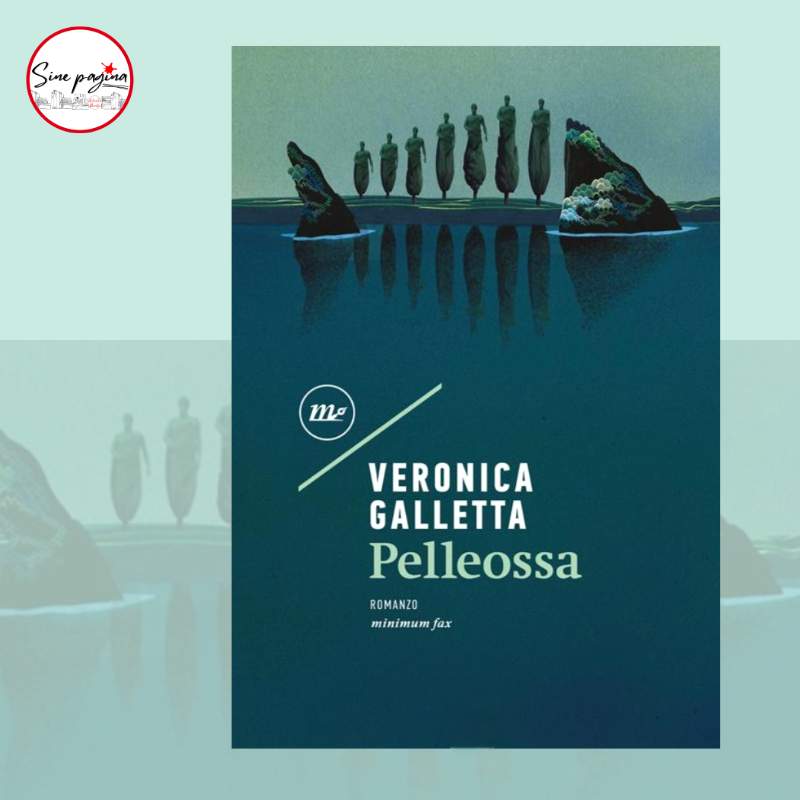Racconto di Antonella Perrotta
Questo racconto è vincitore della Prima Edizione del Premio Internazionale “4 Maggio” per la sezione Narrativa bandito dall’Associazione Culturale Tirrenide APS
“San Franciscu miu glorioso,
santu miu di carità,
iu ti prego,
vieni prièstu alle mie necessità.”
Franceschina recitava la preghiera col tono monocorde mentre lavorava la farina, le uova e il miele per i tradizionali mostaccioli della festa e quell’orazione valeva anche a proteggere l’impasto, affinché risultasse compatto e dolce al punto giusto.
Io la osservavo in silenzio. Aveva il viso arrossato, i capelli color cenere fermati dietro la nuca, le dita delle mani storte per l’artrite, il grembiule da cucina legato alla vita.
Era il primo maggio del duemilatredici.
L’indomani, sarebbero cominciati i festeggiamenti in onore del patrono e lei voleva farsi trovare preparata. Anche il vestito aveva lavato e stirato ché, di abiti buoni, tre ne aveva, uno per l’inverno, uno per l’estate e uno, il più bello, per la festa del santo. Non era mai stata una donna frivola per carattere, votata alla famiglia, al lavoro e al risparmio, piuttosto, ed era lontana per età e costumanze dalle donne moderne, solite cambiarsi d’abito anche più volte al giorno e truccarsi per andare in drogheria come se dovessero andare spose sull’altare. Non provava nemmeno invidia nei loro confronti ché, per lei, non era l’abbigliamento a foggiare una donna, ma la capacità del suo fare. Perciò, impastare i mostaccioli le comportava, oltre alla soddisfazione di rendere omaggio al patrono, anche quella di riuscire in ciò in cui le altre non riuscivano.
Il biscotto mieloso che riproduceva l’immagine del santo era il più complicato: doveva sagomare un corpo proporzionato col saio indosso e i calzari ai piedi e modellare anche il bastone ché, l’effigie di san Francesco di Paola senza bastone, non l’aveva mai vista e probabilmente neppure esisteva.
“Pare buono” disse d’un tratto, ma non capii se si riferisse all’impasto o al tempo.
Mentre lavorava gli ingredienti, aveva più volte rivolto lo sguardo fuori dalla finestra, scrutando il cielo. Se si fosse ingravidato di nubi, significava che il santo ce l’aveva con i compaesani e non gradiva la festa. Se, poi, fosse stato malamente proprio durante il rito della benedizione del mare o durante la processione del busto argenteo, allora voleva dire che la colpa dei paolani era colpa grave.
In paese, così funzionava.
Era il santo a governare le sorti degli uomini e i ritmi della natura. Terremoti e pandemie, alluvioni e siccità, malanni, ma anche gioie e lieti eventi, erano tutti in qualche modo dipendenti dalla volontà e dall’umore, notoriamente permaloso, del patrono che, così come padroneggiava il vento che spirava minaccioso dai monti alle spalle del convento, vegliava dall’alto dei cieli sui destini di coloro che si pregiavano del titolo di suoi compaesani e lo consideravano, prima ancora che protettore celeste, amico, fratello, padre in carne e ossa, ma anche giudice caritatevole o severo.
Così, se errare è umano, non c’era paolano che, temendo la giusta punizione, non gli chiedesse perdono per le colpe commesse ché il suo bastone anche a castigare serviva. E non c’era paolano, anche dichiaratamente ateo, che non nutrisse fede in lui più di quanta ne coltivasse verso il Padreterno.
Per questo, la festa patronale era più che una festa.
Era una comunione di anime e di corpi.
Durava tre giorni: il primo, era dedicato al patronato sulla regione Calabria; il secondo, a quello sulla gente di mare e l’ultimo, a quello sulla città. I riti religiosi che ne segnavano la scansione erano convalidati dalla tradizione: l’accensione della lampada votiva con l’olio degli olivi calabresi offerto dai comuni scelti a sorte; la benedizione del mare e la processione del sacro mantello con cui san Francesco aveva attraversato lo stretto di Messina; la processione del busto d’argento e la consegna delle chiavi della città nelle sue mani.
In questi tre giorni, non c’era tempo se non per la festa, non c’era pensiero che non andasse al santo e non c’era paolano che non si sentisse orgoglioso di poter dire che Francesco Martolilla era un suo compaesano col quale condivideva lingua, tradizioni, luoghi. Era proprio questo senso di appartenenza alla stessa terra madre che, se da un lato, faceva di san Francesco uno di famiglia, dall’altro, rendeva tutti i paolani suoi parenti prossimi e parenti fra loro di conseguenza.
Franceschina impastava in suo onore come quando aveva impastato per i compleanni dei figli, per il matrimonio della maggiore e per il mio battesimo.
Io, sedicenne ribelle e dispettosa che pretendeva di avere ogni risposta in tasca, mi facevo chiamare Mary. Il mio nome è Maria, ma in quegli anni pensavo fosse un nome antico, troppo, soprattutto se messo a raffronto con le Natascha, Kate, Isabell, Zara che spopolavano a scuola. Per questo, lo avevo inglesizzato e quell’ipsilon era bastata a farmi sentire cittadina del mondo. Ma, per Franceschina, continuavo a essere Maria, l’unica nipote femmina, bella come sua figlia e capatosta come suo padre. Né Maria né Mary sapevano preparare i mostaccioli. La forza della tradizione di Maria e quella della modernità di Mary non reggevano alla pazienza che l’impasto richiedeva.
Franceschina sapeva che i dolci, e non solo, li compravo dagli ambulanti sul corso Roma e li mangiavo insieme alle amiche nel peregrinare senza sosta per le vie cittadine nei giorni di festa. Capitava che a casa neanche tornassi per il pranzo o per la cena ché era, quella, l’unica occasione in cui mi era permesso di fare tardi.
Ai riti religiosi si affiancavano, infatti, i festeggiamenti civili. Il paese prometteva nuove avventure, svestendosi della monotonia spenta di ciò che resta sempre uguale. Impossibile, per me, resistervi. Dal fondo delle vie principali e delle vinèdde del centro storico, spruzzi di luci si lanciavano verso l’alto come allegri zampilli: luci delle luminarie, delle bancarelle degli ambulanti, delle giostre, dei fuochi d’artificio, del palco in piazza su cui si esibivano gruppi bandistici e cantanti famosi. Fra esse esalavano odori pungenti, aspri, salati, dolci, e si propagavano musiche, voci e urla, in un ricorrersi e confondersi di suoni che generavano una baraonda cacofonica e invadente che riusciva, comunque, a non essere fastidiosa. Anzi.
Finché sarebbe durata la festa, tutto sarebbe stato tollerabile, persino la puzza di sudore, di polvere e di orina. Soltanto dopo, la pulizia e la disinfestazione delle strade sarebbero state richieste come atti dovuti d’igiene pubblica e le impronte del calpestio dei visitatori e dei venditori accorsi da ogni dove, dei musicisti e pure dei frati e dei fedeli al seguito della processione sarebbero diventate un qualcosa di cui sbarazzarsi, simboli di un tempo interrotto che avrebbe ripreso a scorrere dopo un anno esatto.
Erano i fuochi d’artificio a segnarne la fine.
Franceschina era solita guardarli dal terrazzo di casa, dopo avere assistito alla funzione religiosa celebrata a sera tarda al santuario quando, terminata la processione, il busto del santo rientrava in chiesa fra i cori e gli applausi.
Da giovane, la processione, la seguiva tutta. Piccoli passi scomposti, i suoi, su e giù per le vie ingombre di corpi e sature di umori. Adesso, con gli acciacchi dell’età, per un tratto soltanto, ma la messa non l’avrebbe persa neanche se fosse stata sciancata. Diceva che quella preghiera corale le riattizzava la fede, dandole una sensazione di serenità che le durava per tutto l’anno. La visione dei fuochi, invece, le metteva allegria e pure l’allegria era uno stato d’animo necessario a compensare i silenzi sleali della vita che conosceva bene.
Quando lo scoppiettio terminava, si faceva il segno della croce, continuando a guardare il cielo e gli sbuffi di fumo che fluttuavano nell’aria, e pensava che ancora una volta aveva visto la festa del suo santo. Un altro anno si aggiungeva ai precedenti e segnava l’età pure meglio dei compleanni. “Pure ppi’ ‘st’anno è jiùta” diceva, felice. Poi, si coricava, ma non prendeva sonno fino a che la porta di casa non si apriva, annunciando il mio ritorno.
Anch’io seguivo la messa, mai l’avevo persa. A volte, lasciavo da parte le amiche, raggiungevo Franceschina e me la teneva stretta. Ero contenta e lei pure. I fuochi, invece, li guardavo dalla spiaggia, vicino, ma non troppo, al punto in cui venivano fuori dalla sabbia per accelerare in alto come proiettili.
Sotto il cielo scoppiettante e multicolore, ho anche dato qualche bacio e mi è parso bellissimo. Franceschina l’aveva pensata spesso, questa cosa. Me l’aveva detto: “Ti vasi supa ‘a spiaggia mentre sparano i fuochi, eh?”, ma il tono non era accusatorio. Sapevo che, se da un lato, la turbava la consapevolezza che stessi crescendo, dall’altro, le ritornava in mente quando era cresciuta lei e, una carezza audace sotto il cielo illuminato dai fuochi d’artificio, l’aveva ricevuta col petto gonfio dall’emozione. Perciò, non mi rimproverava. Lasciava che anch’io la provassi, quell’emozione, ché un anno è sempre unico e irripetibile e va vissuto per come viene.
Finì di impastare. Modellò la forma dei mostaccioli con le mani agili dell’esperienza e vi rivolse uno sguardo soddisfatto prima di disporli nella teglia imburrata. Quello raffigurante san Francesco era perfetto.
Continuavo a osservala svogliatamente. “No’, cosa mi regali quest’anno?” le chiesi.
Infornò i dolci e impostò il timer senza rispondermi. Poi, andò in soggiorno, aprì il ripiano basso del mobile in cui teneva custodito il borsellino e tolse fuori venti euro sottratti alla misera pensione sociale. Quel regalo, che mi faceva ogni anno per la festa, era la “fiera”.
“Mi devo comprare le scarpe” obiettai.
“Basta che non li spendi tutti per i biglietti delle giostre” mi ammonì nel darmi altri venti euro, ma entrambe eravamo consapevoli che, se anche l’avessi fatto, sarei stata perdonata. Lei sapeva che il gesto di estrarre i soldi dal vecchio borsellino sarebbe rimasto impresso nella mia memoria, così come, nella sua, il medesimo gesto di sua madre.
Assentii con un cenno del capo e la abbracciai stretta. “Tranquilla. Alla fiera, comprerò le sneakers nuove” le dissi e lei aggrottò la fronte in un gesto interrogativo. “Le scarpe da ginnastica… Hai capito?”
“Ah! Quelle che puzzano e sembrano scarpe da maschio.”
“Si usano così…” risposi e alzai le spalle per sottolineare l’incapacità impotente del passato a star dietro al presente. “E, se avanza qualcosa, pure un paio di orecchini” aggiunsi.
Quelli che si fanno neri per vergogna” obiettò, ma lo fece ridendo. Per lei, sarei stata bella pure con le scarpe da maschio e gli orecchini di paccottiglia.
“Sì, nonna. Quelli” feci e risi anch’io.
Tutto rideva quel giorno: l’aria che sapeva di miele, il forno che emanava calore, la luce che s’infiltrava invadente attraverso i vetri. Pure il miagolio dei gatti randagi aveva un qualcosa di gioioso.
Franceschina si sedette sulla sedia in cucina, aspettando che i dolci cuocessero. Li avrebbe, poi, decorati con pezzetti di carta stagnola colorata inseriti negli intagli delle forme. Nell’attesa, riprese la preghiera al santo e lo ringraziò. Per lei che, di feste in suo onore, ne aveva già viste tante, quel tempo era rubato al tempo concessole nell’attimo esatto in cui era venuta al mondo.
Sorrise al pensiero e assaporò la promessa di festa.
Quella fu, per mia nonna, l’ultima festa del 4 maggio.
Qualche mese dopo si ammalò, peggiorò rapidamente e se ne andò tra il frinire dei grilli.
Da allora, in paese nulla è cambiato: sempre uguali e fedeli alla tradizione i riti religiosi e civili. Sono stati interrotti per due anni di seguito a causa della pandemia che, comunque, non è riuscita a mutare il sentimento della comunità verso il santo. Anzi, l’ha rafforzato.
Io non sono più un’adolescente con ambizioni europeiste. Ora, mi faccio chiamare Maria.
Non ho mai smesso di cercare mia nonna nelle pieghe dei giorni.
Mi accontento delle briciole, accattona che non sono altro. Non ho imparato a fare i mostaccioli.