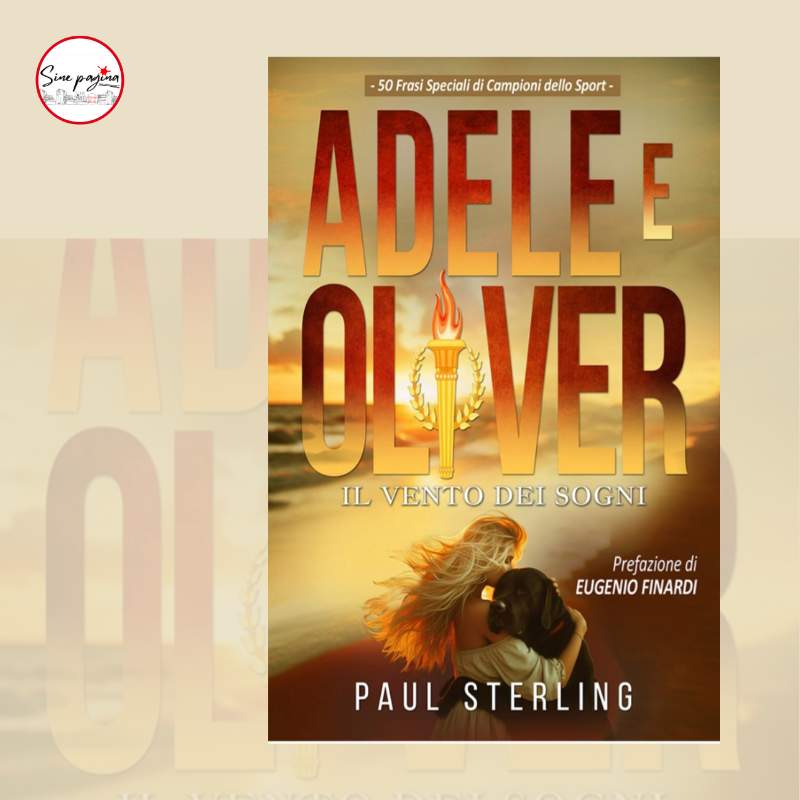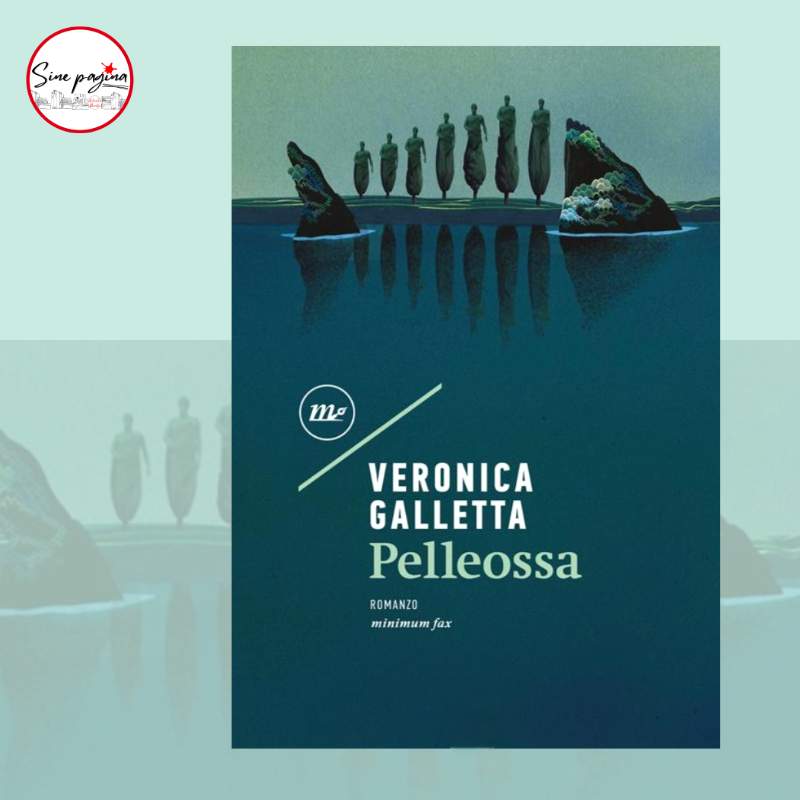Racconto di Loredana Gaudio
C’è un buchino nella calza. Me ne accorgo stirandola.
Dovrò rammendarla; gli strappi vanno ricuciti prima che diventino irreparabili e per farlo bene occorre tendere la stoffa e tenerla ferma su qualcosa di duro. L’uovo di pietra era stata una delle ultime cose che avevo portato con me, lasciando la casa a tre piani che avevo voluto e vissuto con Maurizio, l’uomo che era stato mio marito per ventisei anni. Era un uovo di marmo, della grandezza di quelli di gallina, che mia nonna usava infilare nelle calze per tenderle quando doveva rammendarle e che rotolava da anni sotto le mie dita sulla scrivania dello studio, nell’angolo dei libri e dei post it, quando chiudevo gli occhi, stanca o felice.
Lo tenevo in mano come fossero chiavi, mentre accostavo le porte dell’ascensore di quel palazzo antico che aveva ospitato la mia e la sua inquietudine tra il sesto piano, l’attico e il superattico. Lo avrei riciclato per rompere il guscio delle uova vere, fresche o sode, e pestare le spezie e il sale grosso, rotolandolo sul piano di legno su cui impastavo farina e pensieri nel nuovo spazio in cui avevo traslocato la mia vita. Avevo portato con me solo ciò che era davvero mio da sempre o che mi era stato regalato a titolo personale e avevo lasciato a Maurizio tutte le cose acquistate o ricevute nel tempo insieme. Un tempo che s’era concluso, nonostante fino ad appena tre anni prima non sembrava possibile ad alcuno che accadesse. Tranne a quei pochi che, senza finzioni di giudizio, avevano visto il nostro progetto di vita sgretolarsi come un castello di sabbia abbandonato in pieno sole.
E anche in questo caso, chi poteva davvero credere che avrei cambiato vita alla mia età?
Nella storia con Astolfo, arrivata quando credevo d’essere immune a ogni sentimento, avevo ritrovato le mie “me” abbandonate con cura: bambina, ragazza, giovane studentessa universitaria che ancora andava in bici e non aveva lasciato vincere la paura di cadere. Non avevo il cuore in gola con lui, ma sotto l’ombelico, come quando ti si muove un figlio in pancia: ero di nuovo viva dentro, contro ogni speranza; tuttavia conservavo quel fondo di disillusa malinconia che ormai tappezzava le mie stanze e, più che inseguire un sogno, l’avevo semplicemente continuato a sognare pedinandolo con un bagaglio leggero, come per un viaggio breve, che tale era per forza in quell’ultimo scorcio di vita.
Maurizio, anche questa volta, mi aveva lasciata fare. In fondo lui non credeva che davvero quel giorno di undici anni prima, girandomi a guardarlo, non lo avessi più trovato dentro me, che avessi provato quella sensazione estranea che m’aveva atterrita, sgomenta: eppure avevo urlato per svegliarmi, ma io ero sveglia e lui dormiva. In fondo Maurizio non credeva che fosse possibile per qualcuna lasciarlo per sempre: non era mai accaduto, erano tornate tutte. Tutte. Io le avevo viste. Tutte. In fondo Maurizio non credeva che qualcuno potesse amarmi davvero. E forse era così, ma non aveva messo in conto il fatto che io potessi amare ancora, che non fosse finita per me, che potesse accadere tutto ciò cui anche io non avrei mai creduto: che un uomo che poteva avere tutto avrebbe potuto volere tutto con me. Non lo credevamo neanche io e Astolfo, ma oggi non ci chiediamo come sia accaduto: se serve sapere vuol dire che non c’è più nulla da vivere.
Da quando ci siamo trasferiti a Salina non parliamo molto se non con sguardi, sorrisi e carezze. Tutto ciò che è mancato nella distanza, quando restavamo per ore a raccontarci mentre lavoravamo o guidavamo, travasando l’uno nell’altra la linfa di quella vita che non era stata insieme e che c’era urgenza di condividere in ciò che ne restava tra ricordi, ferite e risate.
Anche il sesso è lento, pigro e pieno. Come accadde la prima volta che avevamo fatto l’amore, dopo più di due anni che ci frequentavamo. Ce ne eravamo tenuti alla larga, nonostante il desiderio, per paura di sciupare un legame perfetto con gelosia e possesso mentre eravamo ancora entrambi legalmente e visibilmente sposati e con figli a carico. Ero andata a prenderlo in stazione a Roma quel mattino del congresso cui doveva partecipare come relatore. Eravamo arrivati in albergo, a due passi dall’auditorium, avevamo fatto la doccia ciascuno nella propria stanza, poi c’eravamo ritrovati nella hall per andare a pranzo insieme. Avevo fatto pace con rughe e cellulite e mi ero concessa una tuta blu con scollo americano e pantaloni larghi, i capelli un po’ più lunghi del solito, ancora abbastanza in ordine nella messa in piega del giorno prima, il trucco leggero che ormai mi dedicavo quasi ogni giorno, non potendo più contare sulla naturale freschezza della pelle giovane, un paio di décolleté con tacco comodo.
Astolfo era perfetto, come sempre: blazer blu, camicia bianca, jeans, clark. Non era bello, di quelli che ti giri a guardarli, ma se ne incrociavi lo sguardo, malinconico e lucido, mentre magari rideva, non riuscivi a liberartene. Mi si era avvicinato, aveva scostato una ciocca dalla guancia e aveva visto gli orecchini di perle. Io avevo sorriso e lui pure. Li avevo indossati per lui, sapevo che erano i suoi preferiti. In quel momento qualcosa era accaduto: con un accordo muto, c’eravamo diretti all’ascensore e dopo dieci minuti eravamo nudi sul letto nella stanza di lui, le labbra incollate senza tregua, le dita nella carne a riprendere spazi non appartenuti. Mi aveva penetrata subito e dopo il tempo infinito in cui m’ero goduta tutta la prepotenza della sua carne turgida, assecondandola con ondate ripetute di desiderio che esplodevano scuotendomi ovunque, ero scoppiata a ridere ricordandogli la sua decantata passione per i preliminari; l’avevo stretto forte, sudato e con il fiato corto, ed ero scappata a fare pipì. Aveva riso anche lui, vedendomi scappare già umida, e avevamo scoperto, come non l’avessimo mai saputo, che ridendo si gode ancora e più a lungo ed è più naturale restare abbracciati, dopo.
Lui sarebbe ripartito all’alba, non ci saremmo rivisti per lungo tempo. Dopo il congresso avevamo passeggiato in silenzio, come vecchi sposi sazi, e tornati in albergo dedicato ancora l’uno all’altra cura, tenerezza e graffi e morsi. Da quel giorno avevamo fatto l’amore tutte le volte in cui c’eravamo visti in quei sette anni clandestini e lui diceva che ormai avevamo recuperato anche il tempo in cui non c’eravamo toccati ed io dicevo no, che il sesso è come il sonno: quello perso sarebbe stato sempre qualcosa che avremmo potuto avere in più rispetto a quello goduto, perché la vita non concede i supplementari.
In realtà quella frase non era proprio mia: Maurizio aveva detto qualcosa di simile un giorno durante il viaggio di nozze, rimproverandomi la resistenza al sesso a tre ed io l’avevo capita bene solo allora. Perché solo allora aveva avuto senso per me: l’intimità che non avevo vissuto prima con Astolfo era davvero qualcosa che sentivo di aver perso.
Con Maurizio non potevo perdere ciò che non avevamo mai avuto: nelle nostre acrobazie pornografiche non c’era stato alcuno spazio per un vero noi. Eppure, se chiudevo gli occhi lo avevo ancora lì, come nelle notti in cui cercavo d’essere felice, che lo tenevo con le dita tra i ricci scuri, lo sguardo incastrato nel verde colza dei suoi occhi. Non riuscivo a smettere di guardarlo quando lo avevo addosso, di passare le mani su ogni centimetro di quel corpo perfetto anche nella vecchiaia e nella malattia, le labbra in ogni incavo. C’era il suo odore nei ricordi, selvatico e acre come quello che restava sui sex-toys prima di lavarli, le pareti della doccia rigate di piscio e sperma. C’era il calco del suo corpo sulla poltrona alta in pelle sulla quale lo lasciavo morire, pretendendo che leggesse ad alta voce mentre, accucciata tra le sue gambe, lo svuotavo lentamente. C’era l’odore superbo del suo pensiero nei libri che avevamo letto insieme, nelle note a margine dove a volte la nostra scrittura era difficile da distinguere se non fosse per la mina morbida che rendeva i tratti di Maurizio più scuri e grassi.
Quanto lo avevo amato? Se poteva chiamarsi amore la mia devozione a quel re.
Quando era finita davvero?
Credo con la bambina. Quella con i capelli lunghi e rossi, vent’anni o poco più. Mi avevano fatto pena entrambi, come due tele d’autore in una discarica; fuoriposto: necessarie testimoni di uno straordinario spreco di talento. Non avevo fatto scenate stavolta: avevo accettato le mie trasferte ed ero rimasta a guardarli distruggersi da lontano. In fondo sapevo che non sarebbe durata, che l’avrebbe succhiata come con le cicale al sugo, lasciandone il guscio vuoto in balia di un domani incerto e senza pace, mentre lui sarebbe rimasto a mordersi le labbra con gusto rapace, carico di rabbia e delusione per la fragilità dell’ennesima vittima.
Maurizio era capace di sottomettere chiunque rimanesse affascinato dalle sue capacità eccellenti di intellettuale e legale, ma non ne godeva, non traeva alcun beneficio dal suo dominio. I colleghi lo temevano e spesso rinunciavano alla difesa in cause nelle quali la controparte s’era affidata a lui. Sapevano che quelle pochissime volte in cui non aveva portato a casa una vittoria risalivano all’inizio della sua pratica legale, quando ancora non aveva affinato le sue abilità di discernimento. Anche le donne che avevano attraversato le nostre stanze in fondo avevano paura già dal primo incontro: di non essere all’altezza della sua prepotente bellezza, di non riuscire a sostenere le sue conversazioni così piene di cose compiute da lasciare spesso muto l’interlocutore. Il nostro legame era dovuto forse anche al fatto che io avevo la capacità di resistergli mentalmente e lui mi desiderava proprio perché sapevo offrirgli altri spunti, altri paradigmi, un altro sguardo sulla stessa vita.
Da quel lavoro fuori sede, comunque, qualcosa in me era andato avanti. Ormai c’era un uomo in ogni mia stanza d’albergo con discreta frequenza. Uomini giovani, intelligenti, belli. Negli anni precedenti non avrei capito cosa ci trovassero nel mio corpo ormai slabbrato, che non aveva le giuste proporzioni con i fianchi larghi e le mammelle appena abbozzate. Cosa potesse attrarli in un involucro di carne che si consuma e scompare. Non ero mai riuscita a spogliarmi prima con un uomo che non amavo. Questo m’aveva aiutava a restare fedele a un matrimonio finito da tempo al quale ancora sentivo di appartenere per quel misto di pigrizia e devozione che aveva corroso all’osso le donne della mia generazione. Era accaduto quando ormai gli anni alle spalle erano sufficienti a darmi misura del mio bisogno di esistere; era accaduto quando potevo finalmente ascoltarmi e capirmi.
Quel giovane scrittore che aveva quasi la metà dei miei anni ed un corpo fresco e sodo m’aveva fatta sentire tranquilla invitandomi a casa per completare la revisione del suo libro. E tranquilla ero rimasta tra le sue mani esperte mentre mi scivolava con la testa tra le gambe sul divanetto rosso. Era stato il primo e negli anni l’unico cui avevo permesso di tornare. L’unico cui avevo parlato di Astolfo, di quella paurosa sensazione di precipitare in una nuova storia d’amore con i miei capelli bianchi sotto la tinta perfetta e i peli diradati sul pube; di curare germogli in un tempo in cui avrei dovuto avere radici salde e profonde. Lo immagino, adesso, quel mio magnifico amante ormai padre, disincantato e stanco nel letto di tante altre e gli sono grata per come mi ha iniziata, con tenera prepotenza, a me stessa, esattamente ventisei anni dopo essere stata iniziata ad altri.
Ci pensavo, stamattina, preparando la valigia, prima che Astolfo entrasse nella stanza con un mazzo di ginestre da sistemare nel vaso sulla scrivania. Tutto ciò che è stato amore o desiderio svanisce, quando Astolfo entra e inonda di struggente malinconia l’aria salata delle nostre stanze; resta in me solo ciò che mi appartiene davvero: gli amici più cari che sono famiglia e quei familiari che hanno scelto di essere anche amici
Ha un gusto naturale per coniugare bellezza e semplicità questo ultimo uomo che mi era è dato in dono. Lo amo in modo insolito, come una marea che monta lenta e non s’abbassa. Non è che non riesco a immaginare un domani la vita senza di lui, proprio mi viene difficile pensare a come avevo vissuto prima senza averlo con me.
Lui torna a Perugia una settimana ogni mese, per la casa, i figli, lo studio che pure in pensione ha un buon giro di clienti. A volte anche io torno in quella che è stata casa dei miei, vedo gli amici, sbrigo qualche impiccio burocratico. Oggi resto sull’isola: ho un lavoro da terminare per la casa editrice e dopo quello che è accaduto preferisco non vedere nessuno per un po’. Pomeriggio ho accompagnato Astolfo al porto, poi tornando a casa ho allungato il cammino, passando dalla spiaggia. Sono rimasta seduta sulla sabbia scura fino a che non s’è fatto scuro pure il mare e dentro me.
La compagna di Maurizio mi ha telefonato la settimana scorsa, martedi. Era martedi perché c’era pollo a pranzo. E Astolfo mi ha vista piangere per la prima volta da quando siamo qui. Serve il mio assenso per una terapia sperimentale molto rischiosa. Maurizio è sedato. In fondo è ancora cosa mia. Non abbiamo mai divorziato; lui vuole che io disponga dei suoi beni, si fida di me, sa che rispetterò la sua volontà testamentaria. Un re resta un re anche se muore. Mi ha camminato addosso: nelle sue mani sono stata sabbia, ne ha fatto ciò che ha voluto. A volte sento i sassi tremare sotto le scarpe e ricordo come tremavo dentro ogni volta che lui minacciava di lasciarmi e mi derideva perché non ero bella o brava come la sua ultima amante. Prendevo la forma che lui voleva. Ma ormai non sono più sabbia. Gli anni addosso mi hanno indurita.
Ho firmato e spedito i documenti da un notaio amico di Astolfo a Messina. L’ho fatto per l’ultima donna dell’uomo che ho venerato. La conosco bene: un tempo, prima di presentarla a Maurizio, era una mia giovane amica. Sono certa che gli è legata davvero, nonostante la differenza d’età. E so anche che lui di cure sperimentali non avrebbe voluto sentire parlare se fosse stato cosciente. Ma se fosse stato cosciente, anche quando lo era davvero, non mi avrebbe lasciata andare via. Saremmo invecchiati insieme ed io gli avrei permesso di morire in pace. Quella donna tanto più giovane e tanto più innamorata, invece, non può capire, ha bisogno che io la liberi da questa scelta atroce. Nessuno forse avrebbe capito al suo posto. Solo lui, ma lui non c’è più.
Mi sono alzata ed ho preso un po’ di sabbia scura nel pugno della mano; avviandomi verso casa l’ho lasciata scivolare sul sentiero. Per strada poca gente, richiamata dalla precoce primavera. Quando Astolfo tornerà riprenderemo le sere in veranda.
Accarezzo il gelsomino, sono stanca. L’uovo di pietra è ancora sul tavolo, dove l’ho lasciato uscendo, accanto alla calza riparata.
Per ricucire gli strappi occorre tendere la stoffa, stressare la trama. Essere pietra, dentro.
Loredana Gaudio è una bancaria per professione e biologa specialista in patologia clinica per formazione e passione. Ha scritto racconti per blog e per una raccolta, un libricino di favole; le piace realizzare miniature, dipingere, lavorare ai ferri e all’uncinetto, leggere, andare a teatro e in sale da concerto. Ama, molto.