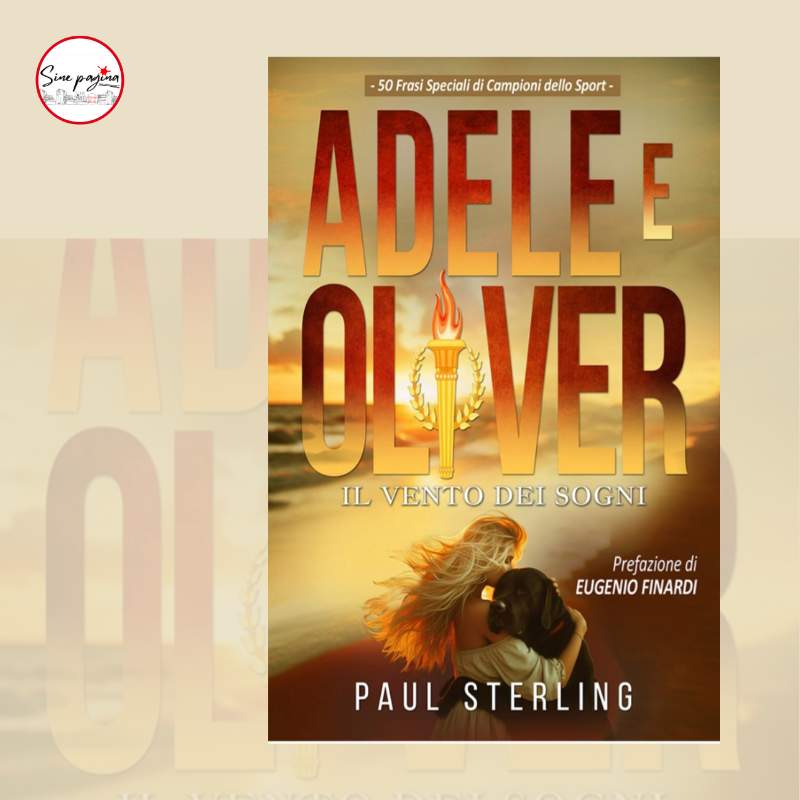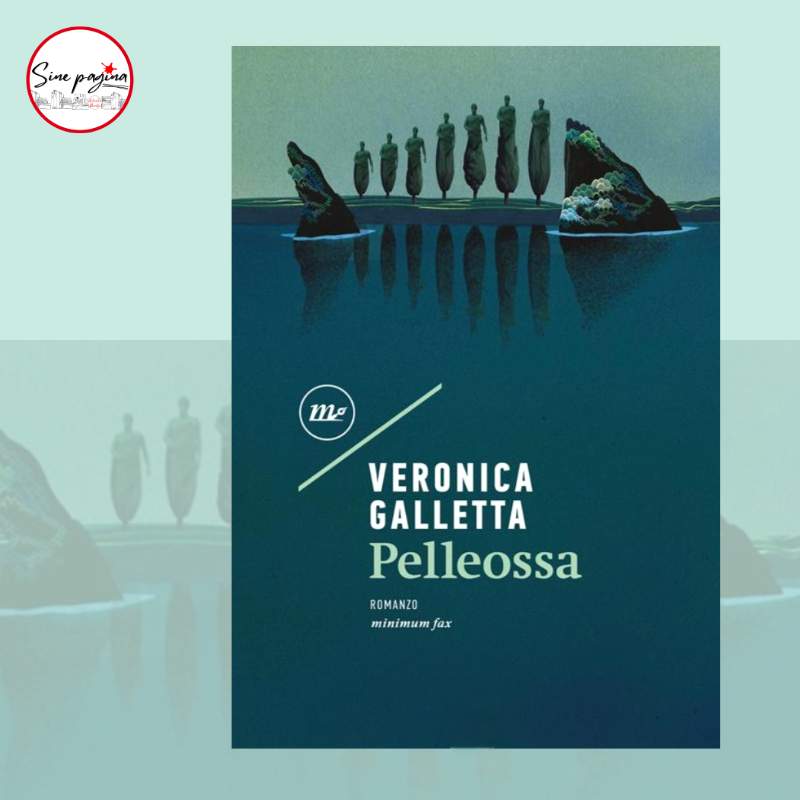Racconto di Antonella Perrotta
Questo racconto di fantasia è stato ispirato da un luogo particolare della Cosenza vecchia, un luogo dove si è fatto e continua a farsi arte, nonostante il suo fondatore e direttore artistico non sia più tra noi
Il teatro dei Ricordi sta nel centro antico della città, seminascosto tra gli edifici in pietra, alcuni dei quali fatiscenti. Vi si accede da una viuzza lastricata a sanpietrini sconnessi, delimitata da alte mura nelle cui pieghe resiste qualche arbusto un po’ rinsecchito. L’odore del cucinato e il tanfo dell’umidità si mischiano insieme per la via, creando un sentore dalle note acide che pizzica il naso, ma, se volgi lo sguardo verso l’alto, è il cielo a dominare, aperto, senza intrusioni.
Un cancello di ferro laccato di rosso su cui campeggia la scritta “Teatro dei Ricordi” in vernice verde è l’ingresso, oltre il quale fa da foyer una stanza minuscola dall’odore di legno stantio che, però, riesce a sapere di buono. Sulla sinistra, due sedie impagliate sembrano incastonate nella parete rivestita con una tappezzeria in raso opaco a righe verdi e rosse. Sulla destra, sta una scrivania in arte povera dietro alla quale siede Umberto, il proprietario.
Umberto è un uomo alto e massiccio avanti con gli anni. Ha i capelli bianchi tirati all’indietro, baffi e barba lunga di poco oltre il mento. D’inverno, veste con completi di velluto a coste e, d’estate, di lino chiaro, porta sempre sul capo un cappello a tesa larga. Saluta con un inchino chiunque entri nel suo teatro, poi si leva il cappello, lo porge voltato al contrario e dice con un sorriso appena accennato: “Una libera offerta.” Si definisce la Tetta degli artisti perché lui l’arte non la fa, ma la nutre come una mammella gonfia di latte.
Il teatro è una grande sala circolare che ricorda una piazza. Dal lato che dà verso nord sta il palco che riproduce una scena fissa: un vicolo illuminato da lampioni, una scalinata ripida di cui non si vede la fine, la facciata di un caseggiato col portone dischiuso e i panni stesi ad asciugare al balcone. Di fronte al palco, al posto di poltroncine, stanno disposte disordinatamente sedie di diversa fattura, tutte di legno, alcune traballanti, alcune tarlate. Sulla parete di sinistra sono appesi mandolini, chitarre e chitarre battenti, violini, tamburi, tamburelli e altri strumenti musicali, mentre, in basso, due violoncelli e un pianoforte sono appoggiati al muro un po’ scrostato. Dal lato opposto, sono gli abiti di scena a dominare dall’alto e due manichini con indosso abiti carnevaleschi dal basso. In fondo, invece, ritratti in seppia e in bianco e nero occupano la parete, mentre diverse lampade in art déco su un antico scrittoio illuminano l’angolo.
Il teatro dei Ricordi apre soltanto un giorno al mese, il mercoledì, per tre ore. Tre ore, tre spettacoli. Da anni, ormai. Da che si ha memoria non un solo spettacolo è andato deserto. Le persone entrano ordinatamente e in silenzio, salutano con un cenno del capo Umberto, lasciano l’offerta nel cappello e prendono posto di fronte al palco. Quando la sala è al completo, le luci si spengono e soltanto il lampione e le lampade vintage conferiscono al locale una luce sfocata.
La serata ha inizio. Silenzio in sala e silenzio sul palco, nessun attore e nessuna sceneggiatura.
Qui, nel cuore antico della città che arranca, cade, si rialza, vanno in scena i ricordi e nessun copione potrebbe essere più complesso, misterioso e accattivante quanto la vita di un uomo. Nessun copione potrebbe esserlo quanto la vita di più uomini insieme. Tutti sono spettatori e protagonisti al contempo, l’immedesimazione è naturale, la catarsi è sperata, la risoluzione è vicina.
Non pensate che in questo luogo non regni la fantasia e tutto si nutra di realtà. I ricordi, in fondo, sono suggestioni, elaborazioni della mente che a proprio modo li custodisce, li edulcora, li ingrigisce, li violenta a tradimento.
Non pensate che lo sguardo sia rivolto soltanto all’indietro ché nulla è, e mai sarà, senza essere stato, ché il passato partorisce il presente e il presente partorisce il futuro.
Nella penombra della sala ognuno si concede un respiro per viaggiare nel tempo, negli affetti, nei luoghi, negli odori, nei suoni e c’è chi si commuove, chi si tortura le dita delle mani, chi abbassa il capo e storce le labbra, chi accavalla le gambe e guarda il palco con l’espressione seriosa, mentre un’energia che è somma di energie si diffonde da un lato all’altro e gli strumenti musicali sulla parete di sinistra iniziano a vibrare e i manichini dal lato opposto iniziano a muoversi e le lampade ad ammiccare e i visi sulle cornici di fondo a ridere, sorridere, piangere.
Si diffondono note lontane e musica e voci e risate e pianti e grida, un insieme di suoni che, magicamente, nulla ha di cacofonico. E sono visi a fare capolino sul palco e tra le sedie traballanti, a nascondersi e poi svelarsi. E sono mani, lisce, callose, sporche di terra, di fango, di pittura, di pomodori maturi o, viceversa, lisce e curate, che accarezzano, si agitano rivolte verso l’alto, chiedono questue e implorano perdoni, scavano fossi, ergono mura. E sono gambe che si muovono, si arrampicano o arrancano, corrono o zoppicano, girano l’angolo dirette alla porta di casa, procedono oltre ricercandone una nuova.
Il silenzio si colma, i ricordi si distendono srotolandosi come terra sollevata dal vento, si fanno annusare, riacciuffare, indossare, brandire.
Lo sa bene Enzo, vedovo e con i figli lontani, che del teatro dei Ricordi non perde uno spettacolo. Prende posto su una sedia impagliata, una qualunque vicina a chiunque, chiude gli occhi, si lascia andare. Nell’aria, l’odore del legno stantio si stempera e prendono il sopravvento le note della salsedine e della rena e il ritratto di sua moglie Gina che esce dall’acqua ridendo e si tira su i capelli bagnati. E, poi, il sentore dei boschi di pino e della terra e dell’erba fresca, di quel giorno che insieme ai suoi figli è andato a funghi senza trovarne nemmeno uno, finché a prendere il sopravvento è il profumo della pelle, quello degli umori dei corpi quando facevano l’amore, quello del borotalco, del latte che fuoriesce da un capezzolo, del sudore sulla fronte, della polvere sul sedile di un treno che porta lontano, del sangue delle ferite.
Dura lo spazio di un’ora. Poi, un campanello annuncia che il tempo è scaduto. Gli spettatori si alzano, si ricompongono, danno un’ultima occhiata veloce intorno ed escono così come sono entrati, in silenzio e ordinatamente, salutando Umberto con un cenno del capo. Enzo con loro, il cuore ricolmo e un abbraccio sulla pelle che gli durerà fino al prossimo spettacolo.
È il teatro dei Ricordi: nel cuore antico della città che sopravvive, va in scena la vita. Qui, nessuno è soltanto membra e sangue. Qui, nessuno è un uomo solo.